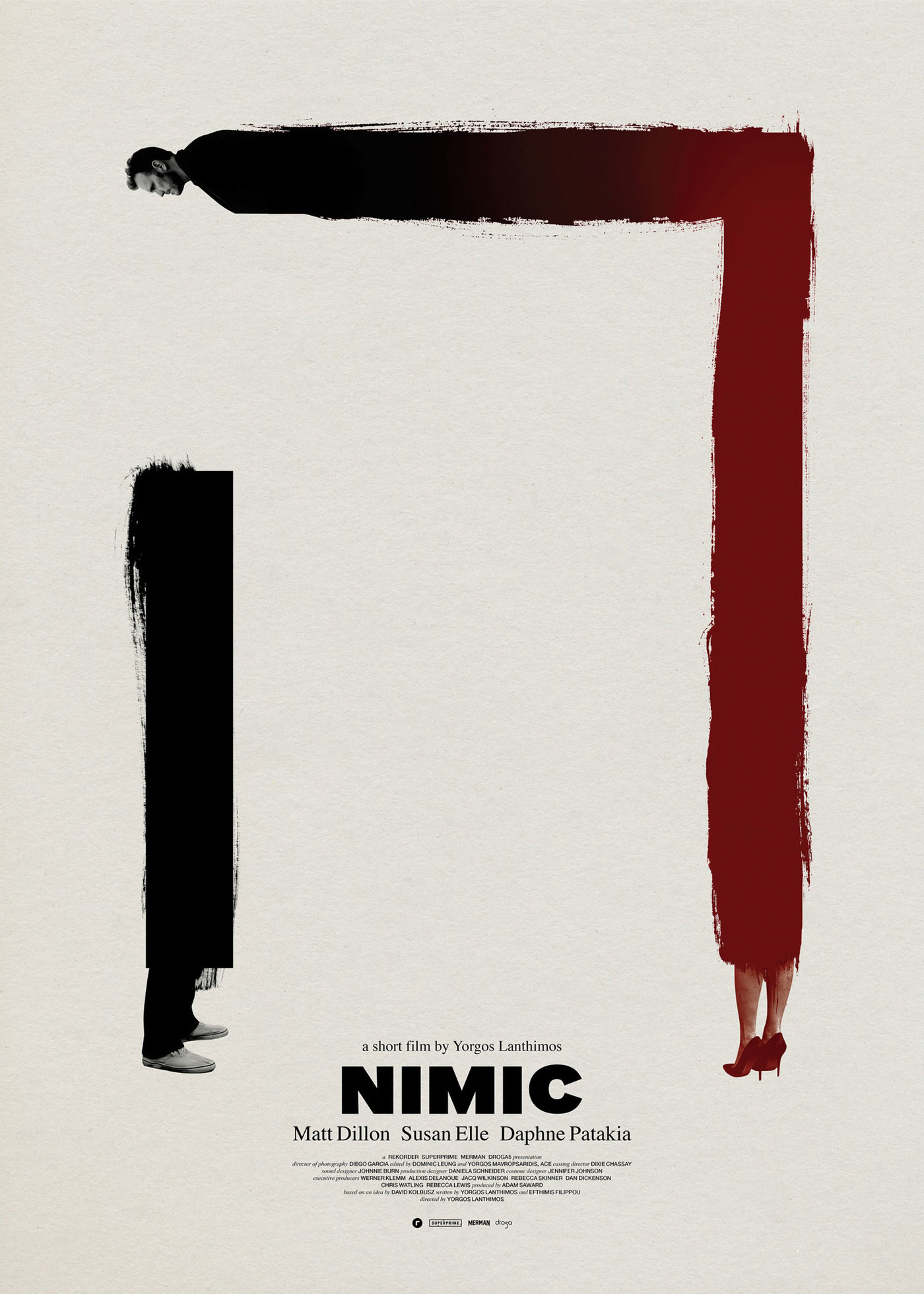Su quel palco per caso con Bird e Dizzy. L'esordio del Divino avviene nel 1944 al Riviera Club di Saint Louis. Dove il giovanotto va per ascoltare la favolosa big band di Billy Eckstine, nei cui ranghi, accanto a maestri della taglia di Art Blakey, Sarah Vaughan, Lucky Thompson, figuravano le stelle supreme del nascente be bop, Charlie Parker e Dizzy Gillespie. Che quella sera però non si sente bene. Un uomo di Eckstine avvicina Miles e gli chiede di rimpiazzarlo. Il ragazzo già suonava da tempo la tromba donatagli dal padre - noto dentista e fulcro affettivo della sua vita - e lui non ci pensa un istante a saltare sul palco, novizio sconosciuto in mezzo a quell'elettissima schiera. Nell'imperdibile, caustica autobiografia scritta col poeta Quincy Troupe (in Italia edita minimum fax), Miles ricorda quella sera come la sua folgorazione sulla via del jazz. "Mi voltai - scrive - e c'era Bird, conciato peggio di una merda. Portava dei vestiti in cui sembrava avesse dormito per giorni, tanto erano spiegazzati. Aveva la faccia gonfia e gli occhi arrossati. Ma era fico, con quell'aria hip che gli riusciva di avere anche quando era ubriaco o strafatto".
La leggenda di Miles Davis, colonna della musica del Novecento
Il 28 settembre 1991 moriva a Santa Monica, in California, Miles Davis, con Louis Armstrong e Duke Ellington il più importante musicista jazz (e non solo) del secolo scorso. Con la sua musica ha definito i confini di innumerevoli stili (dal be bop al cool), ha 'inventato' il jazz rock e negli ultimi anni della sua carriera ha cercato anche una sintesi con il mondo del rap e dell'hip hop. Un vero e proprio genio musicale del Novecento. "Alla gente piace ascoltare musica e pensare a quello che vogliono - aveva dichiarato - Quando suoni come suoniamo noi puoi pensare a quello che ti pare... oppure rilassarti e basta".
Quel nero elegantissimo e individualista. Dettagli, si dirà. Certo, ma estremamente indicativi. A parte i guadagni, comunque sia traduzione d'un primato ottenuto sul campo, si tratta di frammenti di una ben più ampia idea di eleganza, di stile. Intesi non come la somma dei soldi esibiti, ma come modo di raccontarsi al mondo. Di dire agli altri chi è e cosa fa. D'esser dandy secondo la definizione che ne diede Baudelaire: uno così convinto di sé che stabilisce da solo le proprie regole. Al contrario dello snob che imita sempre qualcun altro perché non sa chi è. Tolte le infinite sue profetiche rivoluzioni musicali, dai primi successi personali nella seconda metà dei '40, l'uomo Miles non cambierà più molto. Se non nell'indurirsi di una consapevolezza nera fattasi nel tempo sempre più intransigente. Ma tutta individuale, ripiegata con rabbia in se stessa fino all'autodistruzione, invece che militante o estetica: non farà mai politica in senso stretto, guarderà ostile ogni fermento del free. Troppo difficile e autorecluso Miles non avrà mai fortuna neanche in amore, pur avendo avuto, charmant e inavvicinabile com'era, legioni di belle donne ai suoi piedi. A parte la bellissima Cicely Tyson, sposata due volte e che gli fu decisiva nella battaglia contro la coca e la depressione, una sola l'eccezione, ovviamente fatale: l'amor fou, ricambiatissimo, con Juliette Greco, sbocciato nel '49 quando era in Francia con la magnifica orchestra di Tadd Dameron.
Miles e Juliette, innamorati a Parigi. Fu un momento magico per Miles: nella bellezza assoluta di Parigi e nel Parnaso degli esistenzialisti incontrò l'amore della vita, trovando probabilmente anche la confortante sensazione di esser alla pari fra suoi pari. La Francia, dai primi anni Trenta, grazie a Panassié e il suo Hot Club de France, amava e ascoltava il jazz, diventando dal primo dopo guerra terra promessa di tanti musici afroamericani. Nel '57 un regista raffinato jazzofilo, Louis Malle, ce lo farà tornare per la colonna sonora di Ascensore per il patibolo: l'ininterrotta improvvisazione registrata mentre il gruppo guardava il film fu un'altra delle mille invenzioni del Divino. Al cinema tornerà come protagonista di un raro lungometraggio australiano, Dingo, uscito l'anno della morte, il 1991, e cucitogli addosso su misura dal regista Rolf de Heer: Miles, oltre a firmarne la musica con Michel Legrand, vi interpreta infatti Billy Cross, ossia se stesso. Un celebre trombettista dalla voce scura come la pece e ruvida come carta vetrata, quella vera di MIles non doppiato, suo specchio fedelissimo, che spezza suo malgrado la propria solitudine grazie alle insistenze di un giovane che, apposta arrivato a Parigi dalla sua Australia, lo vuole come maestro. Ancora in attesa di distribuzione invece Miles Ahead, titolo anche di uno dei suoi dischi miliari, recente biopic di Don Cheadle, che dopo la titanica fatica di finanziarlo e completarlo l'ha portato quest'anno al Festival di Berlino e al Biografilm di Bologna.
A proposito di autodistruzione. Anima inquieta per natura, eroina e cocaina saranno eccome presenti nella vita di "The Sorcerer" (lo stregone), così chiamato per la soprannaturale abilità di stillare ambrosia anche dal più sgangherato motivetto di Tin Pan Alley, ma in modo, manco a dirlo, originalissimo. Attratto dall'eroina, nella quale per forza, dato l'ambiente, viveva immerso, all'inizio dei '50 la volle sperimentare, questa la sua versione nell'autobiografia, restandone preda. Ma anche poi, seppur con fatica improba, liberandosene, spinto dall'affetto del padre e dal richiamo inappellabile della musica. Più complesso il legame con la cocaina, della quale farà largo uso nella seconda parte della vita, senza, a quanto se ne sa, abbandonarla mai del tutto. Nel '75, al culmine di una depressione, alla quale non fece certo bene dover andare in tour da spalla di quell'Hancock del quale lui stesso aveva fatto una star, aveva già, ad appena 49 anni, seri problemi renali, di diabete, ulcera, borsite, artrite ad un'anca che gli fu sostituita. L'insistere sulla cocaina stando chiuso in casa davanti alla tv senza più metter mano alla tromba, ebbe conseguenze pesantissime sulla salute di uno che pure da ragazzo aveva coltivato, allenandosi fino in tarda età, un sorta di devozione per la boxe. Era Miles, anche un inguaribile ma sofferto vanitoso, trappola sempre a portata di piede per le persone molto belle e molto dotate. Ridotto com'è, al suo ego è impossibile apparire in pubblico e dal '75 all'80 si eclissa. A quel punto, come accade con le morti dei Grandi, quella sparizione non può che accrescere la sua leggenda. Cosa che puntualmente avviene.
Il colore nero della pelle. Segnato da episodi amarissimi - come la sconfitta a pro di Chet Baker in un referendum di DownBeat di metà 50, quando Davis è già una stella accecante - o orribili - il pestaggio e l'arresto della polizia nel '59 fuori dal Birdland, dove era in pausa durante un set, per il solo fatto che era nero - Miles attribuirà per tutta la vita alla sua appartenenza razziale - verso la quale non è ad ogni buon conto mai stato troppo tenero, come col resto del mondo d'altronde, tolti Coltrane, Elvin Jones, Prince e pochissimi altri - le ragioni di una pretesa sottovalutazione. Percezione in buona parte, va detto, scaturita anche dall'insondabile, cupa, malinconica, tormentatissima ed eternamente inappagata personalità di Miles, che, anche per le prevalenti atmosfere della sua musica, si autodefiniva "Il principe dell'oscurità". Un'oscurità interiore che ha continuato a fendere affidandosi al suo dono. Che in realtà sono moltissimi, compreso il discreto talento di pittore. A muovere dalla sua naturale eleganza puntualmente piena però di sostanza, pensiero e sentimento, puntualmente scaturita da una divinatoria, intuitiva e invincibile tensione al nuovo, alla ricerca, alla pre-visione di ciò che in musica, nel secolo breve, ancora non era stato. E che, nel suo caso, una volta apparso, diverrà nel mezzo secolo a venire luminoso riferimento per tutti.
Dal be bop ai rapper. In una sola vita. Dopo aver detto la sua nell'alto del be bop, grazie anche agli arrangiamenti dell'immenso Gil Evans, Davis traghetta quelle vertigini nelle atmosfere più rilassate e rarefatte del cool jazz, ancora una volta però "scippatogli" dai bianchi della West Coast. Ancora e sempre con Evans, dà vita alle faconde pagine orchestrali dei secondi 50; introduce, col fraseggio naturalmente rilassato e la insostituibile sordina Harmon, i modi eolico e dorico, spostando così il baricentro del suo jazz dall'armonia alla melodia e sviluppando al massimo la naturale, irresistibile vocazione per le ballad. Compositore istintivo, taumaturigco nelle intuizioni ma capace di riconoscere i suoi limiti quanto di dove e a chi chiedere aiuto, Miles farà del suo stile trombettistico un fluire rarefatto, sospeso, come in perenne attesa, in costante dialogo con spazio e silenzio. Che diverrà modello per centinaia, migliaia di "colleghi" famosi e ignoti di tutto il pianeta cui è letteralmente impossibile sottrarsi alla malia di quello "stregone"; fra tanti, limitandosi all'Italia, Enrico Rava e Paolo Fresu. Ma il suo genio preveggente non si ferma certo lì: è ancora lui, con gli inarrivabili quintetti anni '50 e '60, a battezzare e seppellire l'hard bop. Prima di lanciarsi, con MIles in the Sky, 1968, e poi con i leggendari Filles de Kilimanjaro, In A Silent Way e Bitches Brew, 1969, negli abissi insondati del jazz elettrico. Che tanto dovette alla sua insaziabile curiosità e apertura, nel caso rivolte al miglior rock - segnatamente quello black di Sly & The Family Stone e di Hendrix, col quale aveva suonato in privato cercando inoltre una chance discografica frustrata dalla morte del chitarrista - e alle risorse delle nuove tecnologie. Senza scordare la sua vampiresca capacità di attingere all'altrui talento: rubando il mestiere ai compari più vecchi e colti (Gil Evans e George Russel). E formando un'interminabile teoria di colossi che con lui han debuttato. Da Bill Evans e John Coltrane a Hancock, Shorter, Carter e Tony Williams, dagli Zawinul e Jarrett del periodo elettrico al Marcus Miller degli ultimi anni.
Una rivoluzione copernicana. L'ennesimo visionario sincretismo, forse il più clamoroso e fecondo, che però la critica non seppe capire. Ma che divampò come un incendio, producendo l'inarrestabile successo del jazz rock, della fusion o di come diavolo la si voglia chiamare. Del quale, di nuovo, altri (dagli Weather Report agli Steps Ahead) raccoglieranno fama e danari. Anche attingendo a quelle tecniche di studio (loop, registrazioni di studio in diretta e senza soste, massima libertà degli abbondanti organici cui forniva solo pochi accordi, monumentali postproduzioni fino alle celebri copertine psichedeliche) che Miles, alla caccia del pubblico rock, ma pure dei giovani afroamericani, per non perdere terreno, per primo introdusse, con l'aiuto di Teo Macero, nella lavorazione di un disco jazz.
I lampi finali di una carriera senza pari. Da lì alla fine, furono ancora esperimenti. Superlative scommesse di un uomo che aveva ancora moltissimo da dare. Come, dopo i Grateful e l'Isola di Wight di qualche anno prima, quelle con gli Scritti Politti, i Public Image Ltd di John Lydon, e, dal 1981, con le mutanti formazioni di giovani stelle affidate alla direzione di Miller. Ridotto un fantasma, nello stesso 1981 risposa Cicely Tyson, che di nuovo sarà per lui ridosso sicuro. Sono gli anni in cui sul palco sta di spalle al pubblico, misto di rabbia contro se stesso e toccante voglia di continuare ad esserci. Una dualità che ha segnato la vita tutta di quel gigante, come sovente accade, condannato alla più amara delle solitudini. Arrivano i Grammy ma molto di più contano le sue intuizioni ulteriori, anche quella di metter mano a materiali pop scavandone diamanti (chi non conosce l'eccelsa versione davisiana di Time After Time?), tornando così dopo un decennio alle ballad, che nessuno mai ha suonato come lui e che dall'80 si era costretto, punendosi una volta ancora, a non suonare più. Fino all'ultima profezia, uscita postuma nel 1991 e consegnata alla storia in collaborazione col giovane, melodico rapper Eazy Mo Bee. Doo Bop si chiama quel disco, luminoso testamento e allo stesso tempo salto in un futuro allora per nulla prevedibile. Quando rapper e hip hop erano roba sporca, di strada, che importava a pochi o punti, Miles era invece già lì come al solito, a frugarci dentro per vedere cosa cavarne di buono. Ascoltare per credere. Nel 2006 gli daranno anche una poltrona nella Rock and Roll Hall of Fame. Riconoscimento tardivo e inutile. Che con ogni probabilità lo scontrosissimo Divino Miles non sarebbe neanche andato a ritirare. Tutto rapito nel cercare, come sarebbe di certo stato se fosse vissuto fin lì, qualcosa di nuovo da far suo. E nostro.